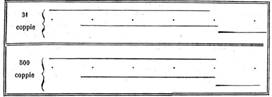3. Sulla eguaglianza di
velocità che le correnti elettriche di varia tensione assumono nello stesso
conduttore metallico[1]
Nel riferire le sperienze eseguite ultimamente in Inghilterra sulle
diverse velocità di trasmissione de’ telegrafi elettrici i cui conduttori sono
sospesi nell’aria o circondati di gutta percha e tuffati nell’acqua oppur
sotterrati entro tubi di ferro o di piombo, accennai di passaggio la teorica
dei Faraday sulla conducibilità; e dissi, che l’illustre scienziato inglese
trovava una conferma di cotale sua teorica nella diminuzione di velocità che si
manifesta ne’ telegrafi sotterranei o sottomarini per rispetto ai telegrafi
aerei. Ecco in poche parole la sua argomentazione.
La conducibilità elettrica consiste in una serie d’induzioni
molecolari propagate successivamente dall’una all’altra estremità del corpo.
Ora, se l’induzione viene in parte sviata dalla sua direzione longitudinale e
richiamata lateralmente, la tensione secondo il verso della propagazione
diminuisce, e con essa la velocità del fluido lungo il conduttore.
Quest’intima connessione, ammessa dal Faraday, tra la tensione e la
velocità del fluido elettrico non mi parve bastantemente giustificata da’ suoi
magnifici esperimenti, e nel rispondere a questo gran fisico credei opportuno
di accennare una esperienza atta a sciogliere direttamente la quistione.
Poniamo, infatti, da banda qualunque considerazione relativa alle variazioni
osservate ne’ conduttori telegrafici di diversa costruzione ed occupiamoci
unicamente della trasmissione delle correnti elettriche più o meno intense
entro lo stesso filo metallico.
Egli è noto che l’azione magnetica di tali correnti dipende ad un
tempo e dalla quantità del fluido elettrico circolante e dalla sua tensione.
Nelle correnti prodotte dall’elettromotore voltaico la quantità cresce
coll’ampiezza degli elementi e la tensione col loro numero. Se fosse pertanto
possibile di procurarsi due pile, l’una composta d’un gran numero di piccoli
elementi, altra di pochi elementi a gran superficie, le cui correnti
possedessero la medesima forza elettro-magnetica dopo di aver percorsa tutta
1’estensione d’una lunga linea telegrafica, si vedrebbe, dal confronto de’
tempi necessarii alle manifestazioni finali delle rispettive loro azioni
sull’ago magnetico, se la tensione influisce, o no, sulla velocità del fluido
elettrico.
Faraday promise d’interporre i suoi buoni uffizii presso la
Compagnia Inglese de’ telegrafi elettrici onde si tentasse l’esperienza. La
proposta, appoggiata da un tant’uomo, venne favorevolmente accolta; e dopo
alcune settimane si diè mano all’opera[2]
e mi si trasmisero le strisce contenenti i segni vergati dal telegrafo sotto
l’azione successiva di varie correnti elettriche più o meno intense. Le due
lettere che accompagnano questi documenti originali sono del tenore seguente.
Istituzione Reale 2 giugno 1854.
Mio caro
Melloni
il signor Latimer Clark ha fatto l’esperimento da voi richiesto, ed
esteso un ragguaglio dei risultamenti: vi mando il tutto qui unito. È assai
difficile avere le linee totalmente libere durante un certo intervallo di
tempo, sicché egli dovette aspettare le occasioni propizie ed operare a più
riprese, come meglio poté, e senza la mia assistenza. Ma io credo ne rimarrete
soddisfatto, giacché potete avere piena fiducia nell’esattezza delle sue
osservazioni.
Tutto vostro affezionatissimo — M. Faraday.
Compagnia elettro-telegrafica (fondata nel 1846)
Uffizio degl’ingegneri, 488 West-Strand. —
Londra 31 maggio 1854.
Latimer Clark al professor Faraday.
Ho fatto alcune esperienze sulle velocità comparate delle correnti
di varia intensità e vi accludo le strisce di carta che mostrano i risultamenti.
Non mi riuscì di uguagliare le deviazioni del galvanometro prodotte dalle
correnti più intense, le correnti, cioè, che derivano da un gran numero di
piccole lamine, con quelle provenienti da poche lamine a gran superficie;
imperocchè nessuna ampiezza poteva supplire alla mancanza di tensione. Alludo
alla forma dell’esperienza suggerita da Melloni; ma credo che i risultati
saranno tuttavia per lui interessanti.
Le sperienze furono eseguite sopra
Nelle prefate strisce la linea superiore, prodotta da un meccanismo
locale, indica il principio dell’esperienza ed il tempo durante il quale la
corrente era trasmessa.
La seconda linea (di punti) significa il tempo in minuti secondi, e
proviene dallo scatto di una mollettina toccata da un pendolo ad ogni suo
passaggio pel centro dell’arco d’oscillazione.
La terza linea mostra l’istante in cui la corrente apparisce
all’estremità da noi detta capo lontano (distant end) della linea di
La quarta linea indica, finalmente, il residuo della scarica del capo vicino (near end)
del filo, che ponevasi in comunicazione colla terra subito dopo il distacco
delle batterie. Ciò non ha nessuna relazione col soggetto delle presenti nostre
indagini.
Ora, si vede per mezzo della terza linea, che in tutt’i casi
trascorsero due terzi circa di minuto secondo prima che l’azione divenisse
apparente alla distanza di
Siccome le strisce di cui è parola nella lettera dell’ingegner
Clark presentano tutte le medesime apparenze, differendo unicamente nelle
annotazioni che indicano il numero e le dimensioni delle coppie impiegate ed
altre osservazioni secondarie, così pongo qui sotto il solo fac simile[3]
delle due estreme, che sono per noi le più essenziali.
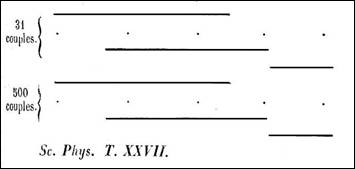
Fig. 1
Riferendomi al mio precedente articolo sulle trasmissioni elettro-telegrafiche,
ricorderò in primo luogo che le linee continue sono prodotte da penne o stili
di ferro adattati al telegrafo stampatore di Bain, il quale lascia
un’impressione stabile sulla striscia di carta preparata chimicamente ed
uniformemente mossa da un meccanismo d’orologeria. E farò poi osservare, quale
novità importante, la traduzione del tempo in linguaggio grafico mediante
l’ingegnoso congegno del Clark: così ognun vede a colpo d’occhio la frazione di
minuto secondo trascorsa fra l’istante in cui la corrente penetra nel capo
vicino e l’istante del suo arrivo al capo lontano.
Noterò finalmente come il genere de’ segni elettro-chimici adottato
dall’ingegner Clark abbia felicemente resa inutile la precauzione ch’io credeva
indispensabile per la riuscita dell’esperienza.
E veramente, egli è certo che la perturbazione dell’ago magnetico,
la calamitazione del ferro dolce, l’attrazione delle spranghe che arrestano i
movimenti delle ruote dentate o qualunque altra azione prodotta dal conflitto
elettro-magnetico esige una certa quantità di forza, la quale può risultare,
non solamente dal primo impeto di una corrente sufficientemente intensa, ma
benanche dalla somma degl’impulsi successivi di una corrente alquanto più
debole. Sicché poteva darsi benissimo il caso in cui gli effetti sensibili
manifestati all’estremità della linea percorsa dalla corrente della pila di 31 coppie apparissero più tardi di
quelli della pila di 500 coppie,
senza che perciò se ne dovesse necessariamente arguire la maggior velocità di
propagazione di quest’ultima corrente rispetto alla prima: ecco perché io
consigliava di compensare coll’ampiezza della superficie l’inferiorità di forza
elettro-magnetica dovuta al minor numero delle coppie. Ma nelle condizioni
sperimentali adottate dal sig. Clark l’azion chimica della pila di 31 coppie, quantunque più debole di
quella proveniente dalla pila di 500,
è tuttavia bastantemente distinta, anche sul principio dell’azione, e
giustifica pertanto la conclusione dedotta da questo valente ingegnere rispetto
all’uguaglianza di velocità delle correnti elettriche di qualunque tensione.
Tra le strisce inviate se ne trova una sola dove la corrente d’un
elettromotore di 64 coppie di
In alcune sperienze il sig. Clark trasmise la corrente per due
galvanometri della Compagnia (non è detto la struttura e le dimensioni di
cotali strumenti) prima d’introdurla nel conduttore, e non trovò nessuna
differenza ne’ tempi della propagazione: ciò che doveva naturalmente
aspettarsi, a cagione della debole resistenza de’ galvanometri rispetto alla
linea telegrafica.
Da tutto ciò si rileva dunque, che allorquando l’elettrico allo stato
di corrente possiede tanta forza che basti a vincere la somma delle resistenze
oppostegli da un dato conduttore di qualunque lunghezza, l’aumento d’una
tensione quindici o venti volte maggiore non altera punto la sua velocità di
propagazione.
Questo fatto è in aperta contraddizione col significato
generalmente attribuito alle denominazioni di quantità e tensione, stantechè
colla prima si paragona la massa dell’elettricità a quella d’un fluido, e colla
seconda figurasi la sua elasticità ossia tendenza al moto.
L’uguaglianza di velocità delle correnti di varia tensione offre,
per lo contrario, un bellissimo argomento in favore dell’opinione di coloro, i
quali suppongono le correnti elettriche analoghe alle vibrazioni dell’aria
sotto l’azione de’ corpi sonori. E per vero, siccome i suoni più o men gravi ed
acuti percorrono nell’aria lo stesso spazio nello stesso tempo qualunque siasi
la lunghezza od intensità delle onde aeree formate dalle pulsazioni del corpo
sonoro, così le vibrazioni più o men rapide e più o men vigorose che il fluido
elettrico concepirebbe sotto l’azione degli elettromotori composti d’un numero
più o men grande di coppie, si propagherebbero ne’ conduttori colla medesima
celerità.
Ognun vede, pertanto, come le ipotesi da noi immaginate per render
ragione de’ fenomeni naturali valgano talora a suggerire certe indagini
sperimentali, donde risultano le dimostrazioni della loro validità od
insufficienza.
Avrò presto l’occasione di esporre in questo giornale (*) altri
fatti i quali dimostrano chiaramente, a mio credere, l’errore di alcune
conseguenze ammesse finora intorno all’induzione elettrostatica e terminerò
conchiudendo di bel nuovo, che la differenza di velocità osservata tra le
correnti elettriche trasmesse dai conduttori isolati nell’aria o profondati nel
suolo e circondati da un doppio strato di sostanze coibenti e deferenti
proviene unicamente da un aumento di capacità. In altri termini: l’induzione
laterale esige una certa proporzione di elettricità, ed il progresso della
corrente nella direzione della lunghezza è tanto più ritardato, quanto è
maggiore la quantità dell’agente necessaria alla produzione del fenomeno.
S’intende poi come dal fatto dell’uguaglianza di velocità di
qualunque corrente nello stesso filo metallico ne risulti che le correnti
elettriche di diversa tensione conservano ne’ conduttori sotterranei quei
medesimi rapporti di quantità ch’esse posseggono ne’ conduttori sospesi
nell’aria; imperocchè la porzione di elettricità sviata, sotto le stesse
condizioni dinamiche, verso le pareti per virtù dell’induzione, essendovi
trattenuta da una forza di reazione, deve necessariamente variare
proporzionalmente all’intensità del fluido circolante.
———
(*) Ciò viene riferito al giornale di Napoli (probabilmente Il Progresso delle
scienze, delle lettere e delle arti – N. d. C.).
[1] Memoria letta da Melloni il 7 luglio 1854 alla Società
Reale Borbonica, ma pubblicata nelle
Memorie della stessa Società solo nel 1856.
Apparve però in altre riviste scientifiche: Corrispondenza
scientifica, n. 27-28, datata 15
luglio 1854, ma uscita con almeno un mese di ritardo perché contiene il
necrologio di Melloni scritto dal Secchi (vedi qui a p. 40); Annali di scienze matematiche e fisiche, 1854, pp. 319-325; Archives
des sciences physiques et naturelles, XXVII, 1854, pp. 30-37.
[2] Vedi L. Clark, Propagation of the electric
current in long submarine telegraph cables,